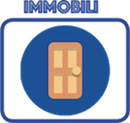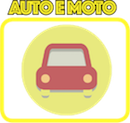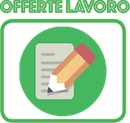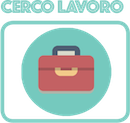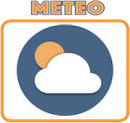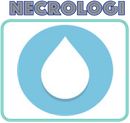All’interno della rubrica “Ossola Rurale” (l’augurio è che la rubrica sia più vostra che mia) consentitemi una riflessione invernale legata alla genuinità dei prodotti della montagna e alla bellezza del territorio ossolano che li produce, in un periodo in cui i coltivi riposano sotto una coltre di neve bianca e gli attrezzi agricoli o le forbici di potatura sono riposti sugli scaffali delle tiepide cantine delle nostre borgate rurali.
La riflessione trae origine da questa semplice domanda: “Cos’è la tradizione alpina dei prodotti gastronomici che portiamo sulle nostre tavole e cosa oggi, in un mondo dominato dalla globalizzazione, questa tradizione sa ancora rappresentare? ”.
Più volte l’eco di questa domanda mi è tornato alla memoria quasi fosse un tormento, e vi confido che pur avendoci ragionato a lungo, non sono riuscito a trovare una risposta precisa.
Intanto il concetto di tradizione, se lo intendessimo come qualcosa di statico o d’immobile nel tempo, è sicuramente un concetto che non esiste.
La tradizione dei prodotti agricoli alpini è una frontiera culturale, prima ancora di un traguardo agricolo legato al territorio, che non esiste perché soggetta a continue mutazioni temporali cui lega la propria sopravvivenza.
Se l’agricoltura di montagna rimanesse statica o si fermasse alle tradizioni dei nonni, non avrebbe futuro, morirebbe. In altre parole, se avessimo continuato a bere il caratteristico “Bruschett” che usciva dalle nostre cantine, o non avessimo migliorato le tecniche casearie o quelle di produzione del miele, oggi non avremmo potuto vantare né la DOC dei vini Ossolani né la DOP del formaggio d’alpe né la tutela del miele prodotto nelle nostre vallate.
Se pensiamo di essere in sintonia con questo primo ragionamento, se cioè ritenessimo che la tradizione dei prodotti agricoli sia in continua trasformazione e sia legata al presente della terra e degli odierni operatori agricoli del territorio, è necessario dare risposta a un secondo quesito, non meno importante del primo: Quando un prodotto può considerarsi alpino o “nostrano” e quando non lo è? E qual è la frontiera che lo qualifica come tale? In sintesi, quello che oggi l’Ossola agricola porta sulle nostre tavole, si può ritenere “nostrano”, cioè legato alla tradizione oppure non lo è?
La conclusione cui sono arrivato, (potrebbe non essere in sintonia con la vostra, ma favorire la discussione era l’obiettivo preposto) è che nessun prodotto agricolo possa o debba considerarsi “alpino” o “nostrano” per definizione o per tradizione, ma che gli stessi prodotti siano diventati tali per necessità o per caso, quale effetto delle scelte che in un determinato periodo storico fecero gli operatori agricoli, in conseguenza delle esigenze alimentari del territorio ossolano.
Pensiamo al cibo che per antonomasia caratterizza il territorio alpino, la polenta, considerata da tutti il piatto tradizionale delle popolazioni di questa parte della penisola. Non fosse esistito il bisogno di sfamare le genti di montagna, il mais, importato dall’America, non sarebbe mai approdato sulle nostre tavole, eppure la polenta è diventata piatto tradizionale.
Identica sorte per le patate che non sarebbero mai diventate un prodotto tipico, con buona pace della varietà “scura” formazzina o macugnaghese che dir si voglia, se non fosse esistita la necessità di sfamare le genti nostrane. Così come i pomodori, le zucche, i fagioli e altri prodotti ancora che andarono ad avvicendare altre colture che si ritennero "impoverite" e degne di sostituzione, sino a diventare “prodotti tradizionali”.
Oggi c’è la corsa alla riscoperta di questi “prodotti di tradizione”, senza considerare come questi altro non furono che la risposta a un bisogno o a una necessità cui dovettero far ricorso i nostri antenati.
Le popolazioni ossolane non cercarono l’introduzione di nuovi prodotti agricoli, ma ne subirono l’immissione, sino a farla diventare tradizione gastronomica, spinti dalla necessità di dover superare periodi di crisi alimentare o di scarsità di cibo. Attualmente addirittura alcuni cibi alpini, considerati un tempo della cucina contadina e pertanto un menu dei poveri, sono stati assunti al ruolo di protagonisti della “cucina alta” e quindi nobilitati.
Effetto del cambiamento dei tempi? In parte è vero. Ma soprattutto sono la conseguenza del cambiamento dei gusti. Oggi che, fortunatamente, non esiste più la scarsità di cibo, siamo spinti dalla necessità, di ricercare qualcosa di “autoctono”, senza pensare, come abbiamo cercato di dimostrare, che il “nostrano” sulle Alpi non esiste.
In conclusione dell’editoriale invernale e dopo aver sfatato l’equivoco del prodotto “nostrano” o di montagna o alpino che dir si voglia, si pone l’accento con semplicità su quanto importante sia quell’irrinunciabile esigenza di dare valore ai prodotti agricoli oggi prodotti in Ossola. Frutti di quel mondo speciale che con pazienza abbiamo saputo far diventare un “bene culturale e gastronomico” della nostra terra.
Ora, occorre innanzitutto sottrarli alla globalizzazione del mercato che tende a livellare la qualità a scapito della genuinità e promuovere iniziative tese a evitare l’abbandono della montagna utilizzando proprio quel marchio di “prodotto nostrano” pur sapendo che nessuna coltura è alpina o “di montagna” per vocazione o per definizione. Continuiamo quindi a produrre e consumare i prodotti ossolani. Ma soprattutto descriviamone il passato e la storia che li ha voluti presenti sulle nostre tavole. Così facendo garantiremmo loro continuità e stabilità, ma soprattutto assicureremmo un futuro alla nostra agricoltura e al territorio di cui immaginiamo un roseo avvenire.
Pier Franco Midali - 18 dicembre 2017