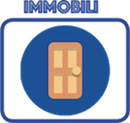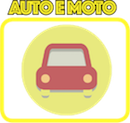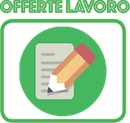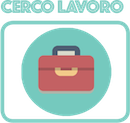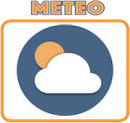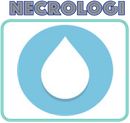E' sempre un piacere vedere che a Domodossola ci sia qualche mostra di notevole interesse, come quella a palazzo De Rodis intitolata “Da Guercino a De Nittis - due collezioni si incontrano”. Ecco, vorrei soffermarmi un pochino su questo tema: due collezioni si incontrano, nella fattispecie quella di Antonio Ceci e di Alessandro Poscio. Due uomini vissuti in epoche differenti, diversissimi fra loro per molti motivi ma che in comune hanno coltivato la passione per il collezionismo di opere d'arte. Più che parlare di Alessandro Poscio, la cui biografia e le cui vicende credo siano arcinote agli ossolani, vorrei illustrare per benino in questo articolo la figura umana e professionale del medico nativo di Ascoli piceno Antonio Ceci (1854-1920), che ha donato alla pinacoteca civica della sua città natale una parte per l'appunto della sua collezione, fatta di centinaia di dipinti di varie epoche e scuole, maioliche italiane e porcellane orientali, mobili antichi con cui arredò la sua villa di Pisa che come scrive lo storico dell'arte Stefano Papetti nell'introduzione al catalogo della mostra, rappresentava il suo buen retiro in cui lo scienziato ritemprava il proprio spirito dopo ore trascorse ad alleviare le sofferenze dei malati nelle corsie d'ospedale o ad insegnare ai suoi studenti universitari. Papetti nell'introduzione si domanda: può un grande scienziato trascorrere la propria esistenza impegnandosi ad alleviare il dolore del prossimo, sempre circondato dalla sofferenza, senza cercare di ritemprare il proprio spirito e sguardo nella contemplazione di quanto hanno saputo esprimere grandi artisti del passato? La collezione Ceci sembra risponderci proprio di sì. Il dottore fu certamente per l'epoca un medico notevole, che per formarsi viaggiò molto nelle principali capitali europee ad apprendere tutto ciò che la moderna chirurgia stava in quegli anni scoprendo e, una volta rientrato in Italia, ad insegnarla nelle più antiche università italiane. Ed è appunto negli anni della maturità che Antonio Ceci scopre la passione per il collezionismo, entrando in contatto con antiquari e mercanti d'arte; ma non con la smania di chi vuol fare un "tanto a chilo", cioè guardando solo la firma dei quadri e basta, bensì con un ottimo gusto selezionatore: basti solamente guardare due emblematici dipinti, la passeggiata amorosa o idillio verde, eseguita intorno al 1902 dall'artista piemontese Giuseppe Pellizza Da Volpedo ed esposta alla biennale veneziana del 1909 e l'eremita penitente del 1720 circa di Antonio Magnasco detto il Lissandrino. Nella prima tela vediamo due ragazzi molto giovani passeggiare a braccetto e conversare serenamente, con sullo sfondo un piccolo boschetto e un pascolo di pecore. E' un quadro di notevole bellezza, che trasmette una serenità non comune sopratutto se visto dal vivo. Dopo la tragica morte dell'artista, avvenuta nel 1907 nel suo studio di Volpedo, il dipinto viene esposto nel 1909 alla biennale Veneta in una sala riservata alle sue opere e acquistato da Antonio Ceci per 1100 lire. Il quadro fa parte del progetto degli idilli, concepito dall'artista intorno al 1898 e che doveva consistere in un ciclo di cinque tondi dedicati all'amore illustranti le varie fasi della vita di un uomo in situazioni amorose. Invece tra il 1901 e il 1902, Pellizza concepisce una serie di dipinti in forma varia. E questa è la serie intitolata "l'amore nella vita", che la dice lunga sulla delicatezza d'animo di un'artista che non ebbe certo una vita facile. La seconda tela è di un epoca e tecnica completamente diverse. Vi è raffigurato un'anziano e scarno eremita, forse un San Girolamo a giudicare dal teschio che guarda fisso fra le sue mani e dal copricapo, tutto rannicchiato sotto il tronco di un albero sul quale è avvinghiata una losca e indefinibile figura, che pare osservarlo di nascosto. Tutt'intorno c'è una natura ostile, un cielo notturno e nuvoloso come se di lì a poco si dovesse scatenare una tempesta. Davanti all'eremita seduto vi è una croce molto rozza, sopra la quale però si apre uno squarcio di luce divina. L'artista era molto avezzo a dipingere scene in cui compare un eremita in un paesaggio e sulla figura eremitica non vi è dubbio che si tratti di una tipica figura "magnachesca"; alcuni studiosi però si sono sempre dibattuti sull'attribuzione del paesaggio dipinto intorno, propendendo per l'ipotesi che sia stato eseguito dall'anconetano Antonio Francesco Peruzzini. A osservare meglio il quadro vi è una pennellata più lieve nel tocco che va via via smaterializzandosi sullo sfondo più lontano e questa non era caratteristica del Peruzzini. Pertanto possiamo attribuire in toto l'opera a Magnasco. Si potrebbe ancora continuare elencando i vari tesori e tesoretti delle due collezioni, ma preferisco invitare i lettori a una bella visita accurata della mostra. Certe emozioni si possono provare solo dal vivo. E c'è tempo fino al 28 Ottobre.
Alessandro Velli - 14 giugno 2017